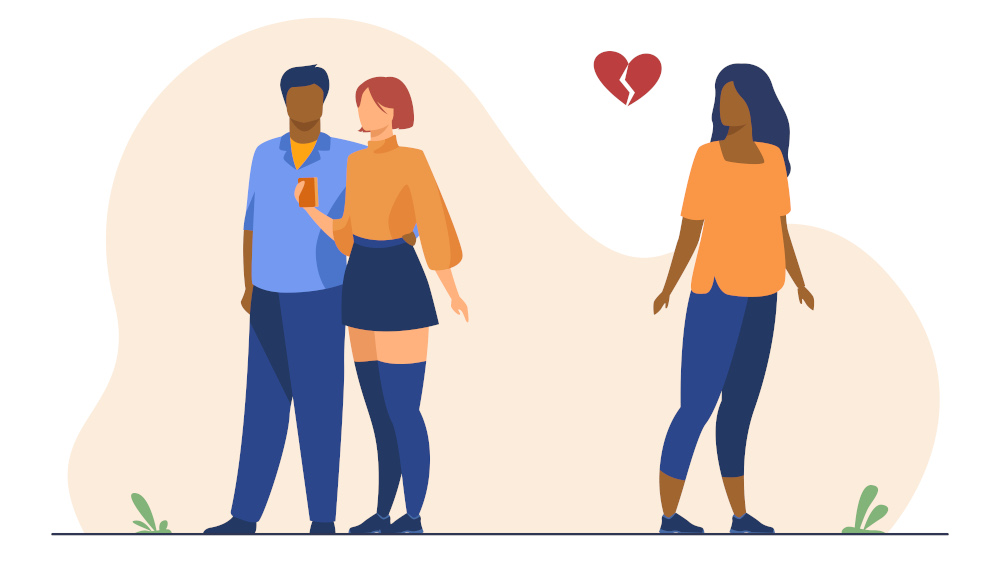Cosa significa Queer?
18 Settembre 2020
L’importanza dell’educazione sessuale nella disabilità
28 Settembre 2020Voler “metter su famiglia”…cosa spinge due persone a progettarsi come un’unità?
Nella natura umana si dice ci sia la necessità di far parte di un gruppo (“l’uomo è un animale sociale” diceva Aristotele), di avere altri simili come punto di riferimento, sia per supporto fisico che morale.
La forma più antica di gruppo è la tribù e la base di ogni tribù è la famiglia (più o meno allargata, in base alle culture e società). In antichità l’aspetto di “futuribilità” del gruppo necessitava di nuove vite, oggi questa necessità si è spostata su aspetti più identitari e individuali, ma che mantengono viva la necessità di far famiglia.
Essere genitori, in tempi più recenti di quelli in premessa, era visto come una necessaria fase nel passaggio dall’adolescenza all’adultità: la fine dell’adolescenza avveniva con la relazione di coppia stabile, legittimata internamente (legame esclusivo, progettualità condivise, ecc.) ed esternamente (matrimonio o altri riti o convenzioni, approvazione delle rispettive famiglie di origine e della società, ecc), era un’esperienza limitata a poche o uniche relazioni, da cui iniziava il progetto di famiglia, in età relativamente giovane, cosa che raggiungeva il pieno riconoscimento all’arrivo del primo figlio.
L’importanza della progettualità
La progettualità personale non era così fortemente intrinseca alla coppia, era spesso frutto di una spinta sociale e di omologazione ad un modello condiviso dove la prospettiva non dipendeva tanto dalla volontà, ma in gran parte dalla “norma” e dall’etica della comunità di appartenenza.
Far famiglia era ancora una necessità del gruppo allargato, sociale, ma si è evoluta verso una forma più moderna, dove, insieme alle necessità di approvazione sociale, c’erano aspetti di motivazione di coppia e personali.
La progettualità personale ha assunto, nel tempo, sempre maggiore importanza, ma più è importante il progetto e maggiormente diviene importante il “chi” ne farà parte e “cosa” darà senso a questa unione. Attualmente prima di avviare il processo di passaggio da coppia a famiglia si vuole avere maggiori sicurezze sulle qualità del partner e quindi si fa un maggior numero di esperienze di relazione affettiva prima di individuare il compagno adatto a questo ruolo. Di conseguenza il processo di creazione della famiglia ha subito un forte rallentamento, il peso della “promessa” ha raggiunto livelli tali da superare quello del timore del giudizio sociale, portando a posticipare la scelta sempre più avanti nel tempo, raggiungendo spesso la soddisfazione di questo desiderio ai primi sentori dell’inevitabilità del tempo che passa.
Per attuare questo progetto emerge un aspetto che nasconde la potenzialità del successo, la motivazione a far famiglia, cosa non generalizzata; il partner quindi non deve sempre ricalcare le caratteristiche di compatibilità, ma può anche essere scelto sulla base dell’evidenza o meno di questa motivazione.
È fondamentale però che i membri della coppia si siano separati e abbiano trovato una loro individualità dalle famiglie d’origine e che abbiano acquisito una posizione adulta, con i dovuti confini, posizioni e desideri condivisi. Se ciò non fosse avvenuto il rischio è quello di trovarsi tra due fuochi: l’impegno della propria famiglia e la presenza delle famiglie d’origine.
La motivazione personale
Altro aspetto imprescindibile è la qualità della motivazione personale, il progetto identitario che ognuno percepisce nella carne, che può, in estrema sintesi, avere queste caratteristiche (Petter, 1992):
- Prosecuzione del nome di famiglia, avere un erede, avere un collaboratore o sostituto;
- Collante per un matrimonio o unione in crisi, che mostra i primi segni di una relazione traballante;
- L’idea che sarà un’esperienza evolutiva, nel piacere di avere a che fare con un bambino, di giocarci, di educarlo e crescere insieme secondo i personali (e di coppia) modi di vivere e percepire il mondo.
Sono tutte motivazioni legittime, anche se le prime evidenziano i bisogni dei genitori mentre solo l’ultima mette in primo piano il bambino, ma esserne consapevoli ci aiuterà a comprendere meglio le nostre modalità di relazionarci al bambino e lo stile genitoriale che ci aspetta.
Il passaggio da coppia a famiglia assume quindi la necessità di un progetto identitario, condiviso con il partner, dove si dovrà far i conti con le rispettive motivazioni, propensioni, dubbi e sicurezze.
Nella coppia che sceglie di fare il passaggio ad una nuova forma, quella della famiglia, si appalesa l’aspetto della genitorialità, ma non solo come elemento (o per meglio dire processo) necessario a garantire la crescita e lo sviluppo del bambino, ma anche come “percezione” condivisa dalla coppia di necessitare di un’ulteriore completezza. E’ una forma di responsabilità, non solo nei confronti della prole, ma principalmente individuale riguardo la propria maturità, dove il passato dovrebbe essere libero da conflitti e dove non ci siano intralci allo sviluppo di successive fasi del ciclo di vita.
Cos’è la genitorialità?
La genitorialità è un processo che emerge nel sentire la spinta ad accudire ed educare un figlio nella cornice dei nostri principi, credenze e visioni del mondo. Non è un tratto della personalità, non è uno stato, ma è una competenza che mette le fondamenta sul desiderio di dare un segno di continuità alla coppia.
In quanto processo si modifica nel tempo, insieme alla crescita del bambino, e si adatta alle sempre nuove necessità che emergono. Probabilmente le origini della genitorialità sono ancora precedenti al desiderio di dar vita a una nuova creatura, si basano sul desiderio di accudire l’altro, di prendersi cura e di condividere (in linea diretta) le esperienze, le competenze e le proprie comprensioni del mondo per dare seguito al lavoro di crescita e sviluppo che ognuno, inevitabilmente, ha compiuto.
Nessuno inoltre ha informazioni innate sul cosa significhi essere genitori, ognuno dovrà confrontarsi con il proprio “esser stato” figlio, con le informazioni raccolte (e i mezzi per raccoglierle non mancano, ma possono creare ulteriore confusione) e le percezioni nuove che emergono dal momento in cui si comincia a pensare a questa nuova opportunità. La genitorialità diverrà quindi l’insieme di queste informazioni, insieme alle aspettative nate nel progetto di famiglia, e acquisirà uno “stile” coerente per lo sviluppo psicologico, fisico, emotivo e sociale della nuova creatura.
Arrivare a comprendere, nella coppia, gli aspetti genitoriali che saranno alla base di questo passaggio, è un dovere imprescindibile; affrontare gli aspetti che possono esser d’ostacolo e le reali motivazioni personali permettono di procedere in un progetto realmente comune, e non solo personale di uno dei membri della coppia. Aver “fatto pace” con il proprio passato, con le dinamiche innescate nella famiglia di origine e la consapevolezza dei progetti personali è qualcosa che non può esser tralasciato e visto “dopo”. Sicuramente la mancanza di una spinta esterna, sociale, può far sì che la responsabilità di tale scelta sia vissuta come un peso, ma siamo anche consapevoli che attualmente c’è maggior bisogno di bambini voluti piuttosto che di bambini “dovuti”, permettendo alle coppie che diventano famiglie di viversi pienamente questa esperienza, senza rinunciare all’identità personale, ma aggiungendo qualcosa senza perdere quello che già c’è.
Bibliografia
- Petter, G. (2007). Il mestiere di genitore. BUR.
- Malagoli Togliatti,M. , Lubrano Lavadera, A. (2002). Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia. Il mulino
- Simonelli, A. (2014). La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia. Cortina Raffaello
- Fruggeri, L. (2007). Famiglie. Dinamiche interpersonali e processi psico-sociali. Carocci ed.